La mostra: “CIMA DA CONEGLIANO: PITTORE DI PAESAGGIO” si è tenuta nella cittadina veneta a palazzo Sarcinelli dal 26 febbraio al 2 giugno 2010.
Pittore di paesaggio perché possiamo vedere, osservando i suoi dipinti, come in essi ci siano delle copie fedeli del territorio natale così come appariva al tempo di Cima tanto che possiamo riconoscerlo e confrontarlo con quello odierno.
Questa mostra è stata molto importante perché è stata la prima su Cima nella sua città d’origine ed è stata la seconda in assoluto sul pittore, infatti l’altra è stata ospitata nel 1962 nel Palazzo dei Trecento a Treviso.
È stata anche la prima volta che le opere esposte sono state riunite tutte insieme, perché alcune di queste facevano parte di collezioni private e altre uscivano per la prima volta dal museo dove erano conservate.
Ma chi era Cima da Conegliano? Il suo vero nome era Giovanni Battista da Conegliano, detto Cima perché i suoi genitori erano cimatori, cioè lavoravano nella preparazione dei tessuti in particolare nella finitura dei panni di lana.
Solo scarsi documenti permettono di ricostruirne la vita.
Egli è nato dunque a Conegliano e la sua casa esiste tuttora dietro il duomo.
La data di nascita (1459 o 1460) non è accertata. Si dice sia stato allievo di Giovanni Bellini, Bartolomeo Montagna o Alvise Vivarini.
Cima aveva una bottega a Venezia, abitava a palazzo Loredan, in campo San Luca; pagava un affitto caro, ma lui se lo poteva permettere perché era ricco, infatti possedeva terreni proprio a Conegliano.
Il fatto che fosse ricco gli consentiva di usare nei suoi dipinti anche materiali preziosi come ad esempio il blu oltremare, che veniva fatto con i lapislazzuli.
Cima è sempre stato molto legato al luogo dov’era nato, si dice infatti che rappresentasse Conegliano nei suoi dipinti perché ne aveva nostalgia; inoltre si sa che, pur vivendo a Venezia, tornava ogni estate a Conegliano. Infatti qui muore nel 1516/7.
La mostra si pone l’obiettivo di ridare a Cima da Conegliano la giusta collocazione nella pittura veneziana, infatti egli è sempre stato poco considerato, forse anche per la sua vita non segnata da episodi significativi come può essere stata quella di un Giorgione, il genio morto giovane.
Spesso è stato ritenuto rustico, un artista poco capace di inventare cose nuove ma solo di copiare ciò che facevano gli altri pittori del periodo. Questo non è vero, basti pensare che se Bellini era impegnato a Palazzo Ducale e quindi era “il pittore del doge”, a Venezia in quel periodo ci si rivolgeva a Cima per commissionare le pale d’altare.
Esaminiamo ora in dettaglio com’è organizzata la mostra: le opere si trovano al piano nobile di palazzo Sarcinelli sono 38, distribuite in 7 sale; l’esposizione segue un ordine cronologico. Tutte le sale sono organizzate in modo da far risaltare l’opera principale di quel periodo. In successione troviamo il polittico di Olera, ancora legato alla tradizione tardo gotica, la pala di Vicenza, dove Cima inizia ad ambientare in esterno le sue opere, la pala di Parma, in cui è rappresentata l’incredulità di San Tommaso, il trittico di Navolè, Raffaele e Tobiolo.
Interessante era la tecnica che egli usava.
Egli dipingeva soprattutto su tavola, che approntava stendendo due strati: uno di preparazione, fatto di gesso e colla, e uno chiamato imprimitura che serviva a rendere più liscia e omogenea la superficie dove poi Cima andava a disegnare. Seguendo poi la traccia del disegno veniva steso il colore. Dato non per strati ma per velature molto sottili che facevano intravedere ciò che stava sotto. Spesso poi nell’ultima fase Cima interveniva con i polpastrelli per ottenere particolari sfumature.
Una tecnica sopraffina quindi la sua, che trova espressione non solo nelle figure ma anche nei cieli e nel paesaggio “…declinato poeticamente in valli e rocche definite dall’intensità di albe e tramonti, che saldano uomini e natura in indissolubile unità” (Giovanni C. Villa).
[print_link]












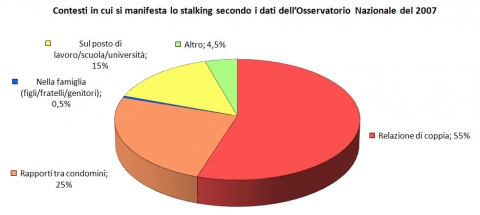

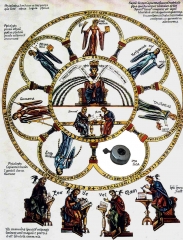
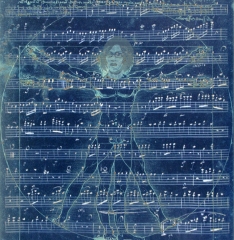









Elogio della normalità
Mi sono resa conto innanzitutto che il termine è molto di moda ed è usato frequentemente nel linguaggio giornalistico e nel politichese per indicare avvenimenti, provvedimenti e riforme presentate come capaci di segnare un’epoca appunto, naturalmente migliorandola.
Ed è proprio questo esclusivo significato positivo, attribuito al succitato aggettivo che suscita un moto di diffidenza e sollecita la mia analisi; continuando quindi nel mio esame della parola da un punto di vista lessicale e connotativo, osservo, ripetendomi che esso può essere correttamente sostituito da “eccezionale”, “straordinario” ed allora la sottolineatura enfatica, celebrativa appare ancora più evidente.
Ad “epocale” poi io associo istintivamente il sostantivo “evento” che mi porta, dritto dritto, al mondo dello spettacolo, di cui è diventato, nel linguaggio comune, sinonimo, ed allora il cerchio è chiuso.
Considerando che il linguaggio è lo specchio di una determinata società in un determinato momento storico, non riesco a sottrarmi al pensiero di una spettacolarizzazione della vita pubblica, sociale e politica con tutte le implicazioni negative o discutibili che questo comporta ed allora ho l’impressione di trovarmi immersa in una comunità separata, in cui ci sono da una parte cittadini-spettatori e dall’altra politici-attori.
A questo punto penso che mi piacerebbe tanto che l’aggettivo in questione venisse usato con meno enfasi compiacente, o venisse sottaciuto, o meglio sostituito, anche implicitamente, da “normale”, termine meno ridondante certo, dal significato forse non del tutto univoco, ma più aperto a valutazioni ed interpretazioni e che fa pensare ad una società in cui leggi e riforme rispondono a bisogni reali dei cittadini che non sentono la necessità di essere stupiti con “effetti speciali”.
[print_link]