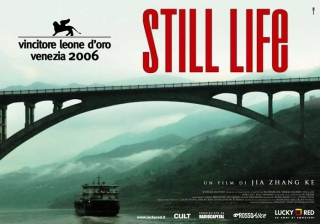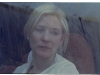Dal 15 settembre 2007 al 6 gennaio 2008 a palazzo Crepadona a Belluno si tiene la mostra “Tiziano: ultimo atto”, in cui la città rende omaggio al suo artista più illustre, il genio della pittura rinascimentale nato a Pieve di Cadore e qui tornato proprio negli ultimi anni della sua lunga vita, quando i grandi d’Europa si contendevano le sue opere ed egli aveva deciso di riorganizzare la propria bottega tra Venezia e Pieve di Cadore.
Ultimo atto perché quest’esposizione si concentra sugli ultimi anni di vita del pittore. La mostra infatti inizia con il documento che attesta la morte di Tiziano.
Interessante è capire il motivo di questa scelta; è molto semplice: nell’ultimo periodo lo stile di Tiziano cambia radicalmente e cambia radicalmente anche il suo modo di vedere la vita .
Per capire meglio bisogna partire dall’inizio; la pittura di Tiziano affonda le sue radici nella pittura tonale veneziana, il pittore è infatti allievo a Venezia di Gentile e Giovanni Bellini e si avvicina infine a Giorgione, accanto al quale è impegnato nel 1508 nella esecuzione degli affreschi del Fondaco dei Tedeschi. Mostra subito segni di indipendenza nei confronti dei suoi maestri, pone a frutto la calma e ferma partitura cromatica di Giovanni Bellini e la modulazione dei toni di Giorgine, attinge un’intensità di colore steso in dinamici contrasti di piani larghi, con la quale afferma una chiarezza nella definizione dei corpi e delle espressioni. Nell’esecuzione (1516-1518) dell’Assunta dei Frari, la sua prima clamorosa affermazione pubblica, esprime carica vitale dei toni ed esprime la visione di un mondo di bellezza armoniosa nel pieno del suo rigoglio e in gara esaltante con la natura.
Da questo momento in poi la sua fama cresce ed entra in rapporto con le più illustri corti italiane. Colore e luce: sono questi i due elementi fondamentali e il segreto dell’arte di Tiziano, in gioventù come in vecchiaia; Tiziano usa il colore come materia che “fa” il quadro.
La pittura degli ultimi anni si differenzia perché vi è una resa dei conti con la vita. Tiziano ha un’interpretazione non più armonica ma drammatica della realtà, di un’inquietudine spirituale che prima non turbava la sua visione limpida e serena dei destini umani.
Ecco la nuova poetica di Tiziano. Il suo ultimo atto.
Come uno scultore che modella la creta, lui stende sulla tela i pigmenti con i polpastrelli; lavora con guizzi di luce che vibrano da dentro il quadro; non definisce le forme e dà un ricercato senso di incompiutezza, quasi ad esprimere l’angoscioso interrogativo del suo animo insoddisfatto, fino all’abbandono di ogni naturalismo.
Restano solo il sentimento, la segreta partecipazione emotiva, i bagliori di un artista disincantato di fronte alla morte.
Per maggiori informazioni: www.tizianoultimoatto.it
[print_link]